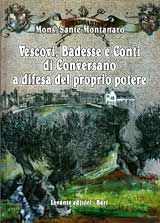
 
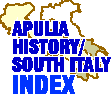



|
|
Mons. Sante Montanaro
VESCOVI, BADESSE E CONTI DI
CONVERSANO A DIFESA DEL PROPRIO POTERE
luglio 2006,
pp. 719, €
50,00
È difficile che un saggio storico, per di più di una storia
apparentemente locale, abbia il fascino dell'attualità e abbia la
capacità di distrarre, sia pure per qualche momento, l'attenzione
della gente dalle vive problematiche dei tempi odierni.
In genere, la lettura delle vecchie carte, la ricostruzione di antiche
vicende e il riesame di controversie ormai sopite sono materia di
interesse erudito e specialistico.
Invece, nella vita svoltasi, per secoli, nel Monastero di San Benedetto
di Conversano, dal dotto Baronio denominato "Monstrum Apuliae",
e nel profilo, storico-giuridico che emeriti studiosi con
intelligenza ne hanno ricavato, l'oggettività di qualche storico molto
serio e l'acutezza di alcuni giuristi-canonisti molto autoritari vi
hanno letto una eloquente pagina della Storia della Chiesa e
dell'esercizio del suo potere.
Un potere che, derivando le sue origini dalla potestà suprema e
universale di governo del Sommo Pontefice, era limitato solo dalle norme
del diritto naturale e positivo divino, e veniva partecipato dalle
Abbadesse mitrate di San Benedetto con l'intensità e nelle forme a esse
consentanee.
Un potere del quale storiche Istituzioni (Vescovi e Abbadesse), pur
soggette alle condizioni del tempo e alle idee feudali, usarono, non
ricorrendo ad abusi o a fatti compiuti, a danno della Chiesa e contro o
al di fuori della sua volontà, ma quale dono di una madre ben
consapevole della sua missione.
Un potere sul quale teologi e canonisti, quando venne usufruito dalle
Abbadesse di San Benedetto, discussero a lungo e animatamente se si
trattasse di giurisdizione, se questa andasse interpretata in senso
stretto o in senso largo, o se si dovesse parlare piuttosto di potestà
dominativa.
Le controversie giurisdizionali, nate nel 1274 con il Vescovo Stefano il
Venerabile e l'Abbadessa Isabella, durarono secoli, ma per molto tempo,
non spente, covarono sotto la cenere, finche una qualche scintilla non
le fece ritornare ad ardere.
Particolarmente vivaci furono quelle degli anni 1659 e 1665 delle quali
protagonista fu il calabrese Giuseppe Palermo, Vescovo di Conversano dal
1658 al 1670, al quale poco mancò che non fosse tolta la vita per mano
di "un'alta e oscura potenza".
Merito delle ricerche recentemente effettuate a riguardo delle
sopradette lotte a difesa del proprio potere da parte dei due
contendenti, è stato l'avere scoperto nel grande Archivio di Stato di
Roma il Fondo Cartari -Febei nelle cui Buste 24, 25, 26, 27, 28, 29 sono
raccolte più di 35 lettere autografe e firmate dal Vescovo di Conversano
Giuseppe Palermo.
In esse, oltre alla luce che viene fatta sull'identità dell'"alta e
oscura potenza", individuata nella nobile e famosa Famiglia
Acquaviva d'Aragona e, più precisamente, in Giangirolamo, conosciuto
come "il Guercio di Puglia", in Isabella Filomarino, la cosidetta
'aspide di Puglia' e in altri membri della Casa, troviamo esatte
informazioni, su le "fiere persecuzioni e minacce" tali da
costringere il Vescovo Palermo, "per aver salva la vita, a rifugiarsi
in un vile abituro di un povero contadino".
Si trattò di una tremenda tragedia che fiaccò e ridusse agli estremi il
povero Monsignor Palermo.
A
completamento dell'operazione culturale da noi compiuta, abbiamo detto
anche una parola su due fenomeni sociali: il maschilismo e il femminismo
dei quali abbiamo trovato tracce nel corso delle nostre ricerche e che
pensiamo possano meglio evidenziare l'attualità e la contestualità del
lavoro.
Sommario: Introduzione
–
CAPITOLO PRIMO - CONVERSANO: IL SUO CENTRO ABITATO E I SUOI TRE CENTRI
DI POTERE:
I. Il Castello
di Conversano,
sede del primo centro di potere:
A. Signori e non ancora Conti di Conversano; B. La Contea di
Conversano e la serie dei suoi Conti: 1. Gli Altavilla, Conti di
Conversano: 1.1. Goffredo Altavilla, Primo Conte, 1.2. Alessandro
Altavilla, Secondo Conte, 2. I Bassavilla, Conti di Conversano: 2.1.
Roberto I Bassavilla di Loretello, Terzo Conte di Conversano, 2.2.
Roberto II Bassavilla, Quarto Conte di Conversano, 2.3. Adelivia, vedova
del Conte Roberto II Bassavilla, Quinta Contessa di Conversano
(1180-1187), 3. La Contea di Conversano sotto il Regio Demanio: 3.1.
Roberto, Regio Camerario (1187-1192), 3.2.Ugone Lupino, 4. I Gentile,
Conti di Conversano: 4.1.Berardo Gentile (1197-1207), 5. Per la seconda
volta, la Contea di Conversano sotto il Regio Demanio: 5.1. Berardino
Gentile (1217-1240), 5.2. Filippo Chinardo (1240-1267), 6. Alla morte
del Chinardi, un periodo oscuro e procelloso per Conversano (1267-1269;
1290): 6.1. Alla morte del Chinardi, 6.2.UgodiBrienne(1269-1290), 6.3.
Gualtieri VI o Gualterotti (1291-1356), 6.4. Ludovico Borbone d'Enghien
(1357-1381), 6.5. Giovanni di Lussemburgo (1381-1394), 6.6. Margherita
d'Enghien (1394-1397), 6.7. Giovanna Sanseverino (1397-1405), 6.8.
Pietro di Lussemburgo (1405-1407), 6.9. Manfredi di Barbiano
(1411-1422), 6.10. Francesco Orsino (1423-1433), 6.11.Maria d'Enghien
(1434), 6.12. Giacomo Caldora (1434-1439), 6.13. Antonio Caldora
(1439-1440),, 6.14. Giovanni Antonio Orsino Del Balzo (1440-1455), 6.15.
Giulio Antonio I Acquaviva (1456-1481), 6.16. Andrea Matteo Acquaviva
d'Aragona (1481-1511), 6.17. Belisario Acquaviva d'Aragona (1495-1497),
6.18. Andrea Matteo Acquaviva, restauratore della Contea di Conversano
(1496-1503), 6.19. Andrea da Capua (1504-1508), 6.20. Andrea Matteo
Acquaviva, per una seconda volta restauratore della Contea di Conversano
(1508-1511), 6.21. Giulio Antonio II Acquaviva d'Aragona (1511-1528),
6.22. Giovanni Antonio Acquaviva d'Aragona (1528-1554), 6.23.
Giangirolamo I Acquaviva d'Aragona (1554-1575), 6.24. Adriano Acquaviva
d'Aragona (1575-1607), 6.25. Giulio I Acquaviva d'Aragona (1607-1626),
6.26. Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona (1626-1665), 6.27.
Giangirolamo III Acquaviva d'Aragona (1665-1681), 6.28. Giulio II
Acquaviva d'Aragona (1681-1691), 6.29. Dorotea Acquaviva d'Aragona
(1691-1710), 6.30. Giulio Antonio III Acquaviva d'Aragona (1710-1746),
6.31. Giangirolamo IV Acquaviva d'Aragona (1746-1777), 6.32. Giulio
Antonio IV Acquaviva d'Aragona (1777-1801), 6.33. Giangirolamo V
Acquaviva d'Aragona (1801-1806) - II.
Le
sedi del secondo centro di potere: la
Cattedrale
e il
Palazzo
Vescovile:
A. La Cattedrale di Conversano; B. Il Palazzo Vescovile:
1. Il Cristianesimo in Puglia: 1.1. La tradizione petrina, 1.2. Il
protovescovo Simplicio, 1.3. Ilario o Ilaro, 2. La serie dei Vescovi di
Conversano, Bibliografia - III.
Il
terzo centro di potere di
conversano:
sedi e titolari:
A. Il Monastero di San Benedetto;
B. La Chiesa di San Benedetto; C. I Titolari del Potere:
1. Elenco degli Abati, preposti, rettori, amministratori di S. Benedetto
di Conversano. Dalle origini al 1266, 2. Elenco delle Abbadesse di S.
Benedetto di Conversano dal 1266 al 1862: 2.1. Elenco delle Abbadesse
riportate da G. Monelli, 2.2. Catalogo delle Abbadesse formato da
Francesco Giuliani, 2.3. Catalogo di Abbadesse redatto da Antonio
Fanizzi
– CAPITOLO SECONDO - GIUSEPPE PALERMO: UN VESCOVO-ARCIVESCOVO FEDELE
ALLA SUA MISSIONE UMANA E CRISTIANA:
I.
Molochio
e il suo territorio
-
II.
Le
origini della famiglia
Palermo
-
III.
La
formazione del
giovane
Giuseppe
Palermo
- IV.
Il
conseguimento dei gradi accademici e la decisione del
Palermo
di trasferirsi a
Roma
-
V.
Il
Cardinale
Marzio
Ginetti
E
Monsignor
Giuseppe
Palermo,
Suo
Uditore,
Bibliografia - VI.
La
nomina di
Monsignor
Giuseppe
Palermo
a
Vescovo
di
Conversano
-
VII. Lo
zelo per il decoro della
Casa
di
Dio:
una nobile passione del cuore del
Vescovo
Giuseppe
Palermo:
A. Le norme del Sinodo sulle sacrosante Chiese; B. La
costruzione della Chiesa di San Giuseppe in Molochio; C. La
consacrazione di alcune Chiese di Conversano: 1. Iscrizione
fornitaci dall'Ughelli, 2. Iscrizione fornita dal Di Tarsia Morisco e
riportata dal Bolognini - VIII.
L'anelito
dell'“Uomo
di
Dio”
a creare una
Comunità
ricca di umanità e coerente nella propria fede cristiana
-
IX.
Le
controversie giurisdizionali del
Vescovo
Palermo
con l'Abbadessa
del
Monastero
di
San
Benedetto
di
Conversano
-
X.
Lo
stato della
Diocesi
di
Conversano
quale risulta dalle
Relazioni
presentate dal
Vescovo
Giuseppe
Palermo
alla
Congregazione
del
Concilio,
in occasione delle visite ad limina degli anni 1661 e 1665:
A. Relazione sullo stato della Diocesi di Conversano nel 1661; B.
Relazione sullo stato della Diocesi di Conversano nel 1665; C.
Sintesi organica dello stato della Diocesi di Conversano realizzata su
approfondita analisi delle Relazioni presentate dal Vescovo Giuseppe
Palermo, in occasione delle visite ad limina degli anni 1661 e
1665: 1. Chiese, 2. Capitolo e Clero, 3. Monasteri e Conventi, 4.
Confraternite e istituzioni varie, 5. Comportamento della popolazione -
XI. Dalla Diocesi
di Conversano all'Archidiocesi
di Santa Severina
in Calabria, della quale
Monsignor Giuseppe
Palermo prese possesso il
1° ottobre dell'anno 1670 - XII. Assoggettato,
durante la permanenza a Conversano,
a delusioni e vessazioni di vario genere, pieno di acciacchi durante il
triennio di arcivescovado a Santa
Severina, Monsignor
Giuseppe Palermo
considerò il suo paese natio, Molochio,
come un'oasi di serenità per il suo spirito, Fonti (abbreviazioni
delle), Bibliografia –
CAPITOLO TERZO - MONSIGNOR GIUSEPPE PALERMO E CASA FEBEI:
I. Pietro Paolo
Febei, Vescovo
di Bagnoreggio,
Bibliografia - II. Il terzogenito
di Pietro Paolo
Febei, l'Arcivescovo
Francesco Maria,
Bibliografia - III. Giovanni
Battista Febei,
Vescovo di Acquapendente,
Bibliografia –
CAPITOLO QUARTO - IL VESCOVO GIUSEPPE PALERMO E IL PRIMO SINODO
DIOCESANO DI CONVERSANO:
Premessa;
I. La Visita
Pastorale della Diocesi
e l'Indizione del Sinodo
Diocesano - II. L'Editto
(Litteras
Edictales)
del
Sinodo
nell'Introduzione
del
Vescovo
di
Conversano,
Giuseppe
Palermo
-
III. Introduzione,
in latino e in italiano, ai 36 capitoli e titoli, in latino e italiano,
dei singoli capitoli del
Sinodo
–
CAPITOLO QUINTO - IL MONASTERO DEI MONACI BENEDETTINI DI CONVERSANO DA
GRANGIA AD ABBAZIA NULLIUS:
I.
la
Bolla
di
Leone
III dell'anno 815:
A. Il testo latino della Bolla dell'815, nella edizione inserita, da
G. Coniglio, nel Codice Diplomatico Pugliese, vol. XX;
B. Riassunto del contenuto della Bolla; C. Il commento critico
della Bolla - II.
Il
“Libellus
liberationis”
dell anno 962
-
III.
Dalla
concessione dell'Arcivescovo
Giovanni
nel 962 alle concessioni del conte
Goffredo
negli anni 1087 e 1098:
A. La munificenza del Conte Goffredo e la grande importanza delle
concessioni degli anni 1087 e 1098 a favore del Monastero di San
Benedetto; B. La concessione dell'anno 1087; C. La
concessione dell'anno 1098 - IV. Dalla
morte nel 1085 di
Roberto
il
Guiscardo,
alla contesa fra i suoi due figli,
Boemondo
e
Ruggiero,
e alla loro riappacificazione nel 1089, con la concessione nel 1107 di
un importante diritto da parte del principe
Boemondo,
al
Monastero
di
San
Benedetto,
per l'appoggio ottenuto da quei monaci a suo favore:
A. Il testo latino della concessione elargita, nel 1107, da Boemondo,
al Monastero di San Benedetto; B. Il regesto e altre
notizie sul rogito del 1107 - V. Con
il
Breve
del 5 luglio 1110, il
pontefice
Pasquale II accolse sotto la
sua protezione e quella della
Santa
Sede,
il
Monastero
di
San
Benedetto
di
Conversano
-
VI.
Il consolidamento materiale e morale del
Monastero di
San
Benedetto
sotto il governo degli
Abbati
simeone (1124-1154) ed
Eustasio
il (1159-1176) -
VII. Un
singolare privilegio di
Eustasio II:
Abate
per grazia del
Re
-
VIII.
Tra la prima decadenza del
Monastero e il ripristino della vita
claustrale, l'amministrazione del
Monastero di
San
Benedetto fu affidata
dalla
Santa
Sede al
Vescovo di
Dulcigno, Nicola
-
IX.
Uno scisma all'interno della
Comunità monastica e l'errato orientamento
dei
Monaci nelle vicende politiche del tempo, determinarono la
diserzione totale del
Monastero, nonostante un estremo tentativo del
Pontefice
Alessandro IV di impedirne la catastrofe –
CAPITOLO SESTO - DIFESA E INCREMENTO DELL'ABBAZIA NULLIUS DI SAN
BENEDETTO IN CONVERSANO, DA PARTE DELLE BADESSE MITRATE CISTERCIENSI:
I.
Conversano e la sua
Contea sotto gli
Angioini
-
II.
Il
Monastero di
San
Benedetto di
Conversano sotto l'Abbadessa
Cisterciense
Dameta -
III.
L'Abbadessa
Dameta e la sua comunità, favorite dal
Re
Carlo d'Angiò, ottengono anche
la speciale protezione del
Papa
Gregorio X -
IV. I
lunghi periodi di governo delle grandi
Abbadesse:
Isabella (1271-1296),
Adelina (1296-1315),
Maria d'Angiò (1326-1341),
Costanza (1349-1365):
A. L'Abbadessa Isabella; B. L'Abbadessa Adelina; C. L'Abbadessa
Maria d'Angiò; D. L'Abbadessa Costanza da Lecce - V. La
decadenza del
Monastero nella 2a metà del secolo XIV e le
Abbadesse del secolo XV
-
VI. Le
Abbadesse del
Monastero di
San
Benedetto di
Conversano e la
Casa
Acquaviva d'Aragona nel secolo XVI –
CAPITOLO SETTIMO - I PRIVILEGI E LE ESENZIONI DEL MONASTERO DI SAN
BENEDETTO DI CONVERSANO, STUDIATI SOTTO IL PROFILO GIURIDICO:
A. I PRIVILEGI GODUTI DAI MONACI DEL MONASTERO DI SAN BENEDETTO DI
CONVERSANO FINO ALLA LORO FUGA INTORNO AL 1266: I.
Le
prime esenzioni:
A. La tutela apostolica; B. Le prime esenzioni dalla
giurisdizione episcopale; C. Esenzione completa, comprendente,
cioè, il Monastero di San Benedetto - II. La Bolla di
Alessandro IV: A. Conferma dell'ordine monastico e dei suoi
beni; B. Le libertà del monastero; C. La pace nel chiostro
- III. Il Monastero di San Benedetto di Conversano e la Santa Sede: A.
Dovere della Santa Sede di intervenire nelle cose del
monastero; B. L'Abbazia Nullius conversanese - B. I
PRIVILEGI DELL'ABBAZIA NULLIUS DI SAN BENEDETTO DI CONVERSANO
DALL'ANNO 1266 ALLA PRIMA DECADE DEL SECOLO XVIII: I. I
privilegi dell'abbazia
Nullius di
San
Benedetto di
Conversano:
origine, trasmissione e incremento di quei privilegi: A. I
primi documenti pontifici a favore di Dameta e
delle monache cisterciensi, venute dalla Romania; B. Le prime
controversie con i Vescovi vicini; C. Le conferme
pontificie del secolo XIV; D. Nomina di rettori di
Chiese; E. La giurisdizione sui chierici - II. La difesa dei
privilegi giurisdizionali del Monastero di San Benedetto di Conversano:
A. Le liti giurisdizionali dei Vescovi di Conversano con le Abbadesse
del Monastero di San Benedetto di Conversano nel secolo XVII: 1.
L'Abbazia Nullius anche sotto le Abbadesse cistercensi, 2. Le
Abbadesse e il Clero di Castellana, 3. Alla ricerca di una spiegazione
soddisfacente dei poteri giurisdizionali concessi nei secoli passati
alle Badesse di San Benedetto di Conversano - III. L'ossequio
del baciamano e gli usi della mitra e del pastorale: A. Cerimonia
della pubblica intronizzazione
–
CAPITOLO OTTAVO - LE ABBADESSE DEL MONASTERO DI SAN BENEDETTO DI
CONVERSANO E LA DIFESA DEI LORO PRIVILEGI GIURISDIZIONALI NEI SECOLI
XVII E INIZI SECOLO XVIII:
I.
Personaggi ecclesiastici, direttamente protagonisti delle
controversie giurisdizionali svoltesi in
Conversano, nel secolo XVII:
A. I vescovi di Conversano: 1. Fr. Vincenzo Martinelli,
dell'Ordine dei Predicatori, Vescovo di Conversano dal 18 agosto 1625 al
20 settembre 1632, 2. Giuseppe Palermo, Vescovo di Conversano dall'8
dicembre 1658 al 1 settembre 1670, 3. Andrea Brancaccio, Vescovo di
Conversano dal 13 gennaio 1681 al 18 aprile 1701; B. Il Capitolo di
Castellana; C. Le Abradesse Mitrate - II.
Personaggi laici, indirettamente
protagonisti delle controversie giurisdizionali svoltesi in
Conversano,
nel secolo XVII e inizio secolo XVIII: A. Adriano Acquaviva
d'Aragona, XXX Conte di Conversano (1575-1607); B. Giulio
I Acquaviva d'Aragona, XXXI Conte di Conversano (1607-1626); C.
Giovanni Girolamo (Giangirolamo) Acquaviva d'Aragona, XXXII Conte di
Conversano (1626-1665), Fonti e bibliografia; D. Cosimo Acquaviva
d'Aragona, Duca di Noci, Fonti e bibliografia; E. Giangirolamo
III Acquaviva d'Aragona, XXXIII Conte di Conversano (1665-1681); F.
Giulio II Acquaviva d'Aragona, XXXIV Conte di Conversano (1681-1691)
- Duca di Noci e Duca di Nardò; G. Dorotea Acquaviva d'Aragona,
XXXV Contessa di Conversano (1691-1710); H. Isabella Filomarino
- III.
Avvenimenti e Documenti
importanti: A. Il Concilio di Trento; B. La Bolla "Inscrutabili
Dei Providentia" di Papa Gregorio XV nel 1623; C. Il Breve di
Alessandro VII del 12 giugno 1665 - IV.
Circostanze fortuite
–
CAPITOLO NONO - STORIA E RISVOLTI DOLOROSI DELLE LITI GIURISDIZIONALI
AVVENUTE FRA I VESCOVI DI CONVERSANO E IL CAPITOLO DI CASTELLANA, DA
UNA PARTE, E LE ABBADESSE DEL MONASTERO DI SAN BENEDETTO DI CONVERSANO,
DALL'AL TRA, NEL SECOLO XVII E NEL PRIMO DECENNIO DEL SECOLO XVIII:
I. La rivendicazione nel 1630, da parte del
Vescovo
Vincenzo
Martinelli
dei suoi diritti di
Ordinario del luogo e la viva reazione del
Monastero
di
San
Benedetto
- II.
Nel
1659, il primo tentativo del
Vescovo
di
Conversano,
Monsignor
Giuseppe
Palermo,
di riprendere, contro il
Monastero
di
San
Benedetto,
la controversia per l'attuazione integra
e senza alcuna discriminazione della
Bolla
Inscrutabili di
Papa
Gregorio XV
- III. Il rinnovarsi, nel 1665, della lotta giurisdizionale
tra il
Vescovo di
Conversano
Monsignor
Giuseppe
Palermo, e il
Monastero
di
San
Benedetto di
Conversano: dal "breve" di papa
Alessandro vii del
12 giugno 1665 alle "minaccie e alle fiere persecuzioni di un'alta e
oscura potenza"
- iv. un accenno ai rapporti giurisdizionali intervenuti
fra il
Monastero di
San
Benedetto di
Conversano e la cittadina di
Castellana sia in temporalibus e sia in spiritualibus,
concludendo la nostra ricerca al primo decennio del secolo xviii:
A. La giurisdizione temporale del Monastero di San Benedetto
sul feudo di Castellana; B. La giurisdizione spirituale del
Monastero di San Benedetto in Castellana – CONCLUSIONI – APPENDICE –
FONTI MANOSCRITTE E BIBLIOGRAFIA: A. Abbreviazioni archivistiche;
B. Bibliografia – GLOSSARIO – IL PITTORE TONY PRAYER E LE
ILLUSTRAZIONI DELL'OPERA.
In copertina: acquarello del maestro Toni
Prayer
ISBN 88-7949-419-8
|
|
![]() LEVANTE EDITORI - Via Napoli 35 - 70123 BARI - ITALY - ISBN CODE 88-7949 - tel./fax +39 80 5213778 -
e-mail: levanted@levantebari.it
LEVANTE EDITORI - Via Napoli 35 - 70123 BARI - ITALY - ISBN CODE 88-7949 - tel./fax +39 80 5213778 -
e-mail: levanted@levantebari.it